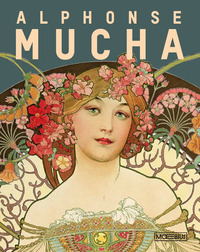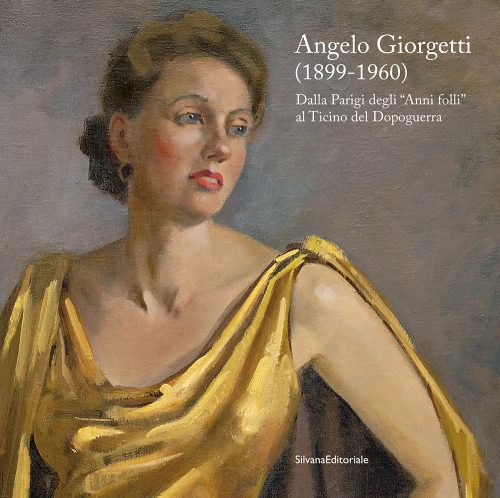Lo spettacolare trionfo di san Carlo Borromeo nella Foligno del 1613
Lo spettacolare trionfo di san Carlo Borromeo nella Foligno del 1613
Il libro si articola in più sezioni. Dopo un inquadramento iniziale nel quale il curatore del volume, Fabio Bettoni, muovendo Da quest’angolo di mondo, si rivolge alle lettrici e ai lettori, segue una prima sezione dedicata al “trionfo” borromeico del 23 giugno 1613. Viene proposta in ristampa anastatica la Descrittione dell’apparato et processione delle sacre reliquie di s. Carlo Borromeo, un testo di 45 pagine scritto da Curzio Cirocchi. L’anastatica permette di addentrarsi agevolmente tra i meandri di una narrazione non priva di fascino. Complesso e articolato, il racconto muove dal 1612, e, dopo aver illustrato gli antefatti, descrive minutamente l’evento del 23 giugno, spingendosi fino al 28 luglio, giorno nel quale fu deposta la prima pietra di quella che sarebbe diventata la chiesa di San Carlo. Il racconto di Cirocchi è stato ripercorso e analizzato da Elena Laureti con un saggio dal titolo significativo: Fenomenologie celebrative, a chiarire come l’effimero si faccia fatto reale, formando il substrato, l’umore profondo di un apparato scenico-scenografico e di una processione esemplarmente barocca. Ma le pagine del “descrittore”, oltre a restituirci gli avvenimenti nella loro sequenza, propongono una quantità notevolissima di componimenti poetici, motti, iscrizioni, citazioni bibliche: tutti interventi tesi ad esaltare la figura del Borromeo e le reliquie che, trionfalmente esibite lungo le vie cittadine, dovevano diventare il fulcro del culto nascente. Qui il latino è la lingua egemone, un latino elegante, che, se configurava allora un messaggio elitario, oggi risulterebbe incomprensibile ai più. Attilio Turrioni, nel suo contributo dal titolo Il latino negli eventi, favorisce con traduzioni impeccabili la comprensione di quei testi. Tra i componimenti spicca comunque un’Oda in lingua italiana, dedicata al Borromeo: il “descrittore” la pone a chiusura dell’opuscolo celebrativo, Elena Laureti ce la rende accessibile, e soprattutto suggerisce di rilevarne una possibile funzione, quella di essere stata predisposta per una partitura musicale di cui peraltro nessuna notizia è pervenuta fino a noi. I documenti proposti avrebbero destato nei lettori qualche inevitabile curiosità. Qualcuno, ad esempio, avrebbe potuto gradire notizie su Curzio Cirocchi, il narratore; altri, incuriositi dalla qualità letteraria degli epigrammi esastici di Marco Antonio Bonciari, potevano chiedersi chi fosse costui. Bruno Marinelli rispetto a Curzio, Lucia Bertoglio nei confronti di Marco Antonio hanno delineato profili biografici e intellettuali illuminanti. Infine, come si potevano trascurare i Barnabiti, ovvero il motore di tutta la vicenda? Come si poteva dimenticare il bel monumento che la loro tenace azione realizzò e che tuttora vediamo ergersi in via Aurelio Saffi, sia pure destinato a funzioni diverse da quelle originarie? Ecco dunque i saggi che compongono l’ultima parte del volume: Roberto Tavazzi scrive su La Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo. Origini e primi sviluppi; Fabio Bettoni e Bruno Marinelli si concentrano su I Barnabiti “maestri di scuola” in Foligno; Saverio Sturm introduce il tema de I nuovi ordini e il Barocco religioso in Umbria; Irene Giustina descrive La chiesa di San Carlo in Foligno e l’architettura barnabitica nel primo Seicento umbro, studio che dà in Giovanni Ambrogio Mazenta il probabile architetto della chiesa. Completano il selezionato corredo iconografico del volume due disegni di Vladimiro Cruciani: uno dedicato alla fronte della chiesa carolina, uno alla restituzione assonometrica dell’interno: entrambi preziosi, ma il secondo in modo particolare giacché l’aula ecclesiale oggi è una sala teatrale. Il libro, scrive Bettoni “non è un’opera apologetica. Non esalta un evento devozionale di quattrocento anni fa. Non è un libro su Carlo Borromeo. Non sugli esiti locali della controriforma cattolico-tridentina. Non sui Barnabiti. Questo libro getta uno sguardo sulla storia di questa città e guarda al mondo esterno da quest’angolo di mondo. Storia di una città e di un territorio usciti da una gravissima crisi di sussistenza che aveva travolto la popolazione, come altrove del resto, nell’ultimo decennio del Cinquecento. Sotto questa luce, la celebrazione borromeica da cui abbiamo preso le mosse fu il ‘trionfo’ spettacolare non solo e non tanto di un santo venuto di lontano, catapultato a forza dai lidi tridentini, ma fu il ‘trionfo’ della città: nobiltà, cittadinanza e plebe. Quando le reliquie vennero a ‘pompeggiare’, la fase più acuta della crisi era relegata nel ricordo, ma, seppur domata, la crisi non era sgominata; l’economia aveva superato il ciclo depressivo più aspro, ma non poteva considerarsi tornata nelle condizioni in cui si trovava intorno al 1590 quando la crisi aveva cominciato a manifestarsi. Nel 1613, la fiera grande che costituisce il sottofondo delle pagine descrittive di Cirocchi stava facendo sentire il suo influsso tonificante. L’estate appena cominciata sembrava promettere bene; la pianura bonificata e le colline alberate, popolate da fibre vegetali preziose come la canapa, da cereali ormai giunti a maturazione, da viti maritate e oliveti chiusati, facevano pensare a buoni raccolti. I frutti che distinguevano la nostra campagna e la nostra economia rurale – canapa, cereali, vino, olio – furono racchiusi nella pietra posta a base del nuovo tempio e ciò non poteva che essere di buon auspicio. Quello che succedeva al di là delle mura urbiche e del contado, ci interessava quel tanto che si rifletteva o poteva riflettersi sui nostri destini. Per il resto, era tutto nelle mani del Signore. L’importante era che i poveri non oltrepassassero i limiti consentiti, le prostitute non si facessero vedere in giro, gli zingari poi…, e ‘li giudii’…; ognuno, insomma, stesse al suo posto: nobiltà, cittadinanza e plebe; possidenti, mercanti, professionisti, artigiani, merciai, salariati e contadini; prelati e basso clero; frati, monaci e monache; bargelli e birri e carcerati. La società era data in un certo modo; restasse così com’era; prosperasse chi era in grado di prosperare. Nel 1613, nulla si poteva sapere dell’imminente guerra dei Trent’Anni e di ciò che avrebbe potuto significare anche per noi, nonostante fossimo così lontani dai teatri di quei terribili eventi”.
- N° scheda: D0390047728
- ISBN-13: 9788898428038
- Autori: Bettoni, Fabio
- Città: Foligno (PG)
- Editore: Il Formichiere
- Anno: 2013
- Mese: Settembre
- Numero pagine: 352
- Dorso: 25 cm
- Peso: 880 gr
- Paese: Italia
- Lingua: Italiano
- Condizione: Nuovo
- Tipo di pubblicazione: Monografia
- Articolo (L', Il, La, Lo, ...): Lo
- Curatori: Bettoni, Fabio
- Indice in PDF: Visualizza